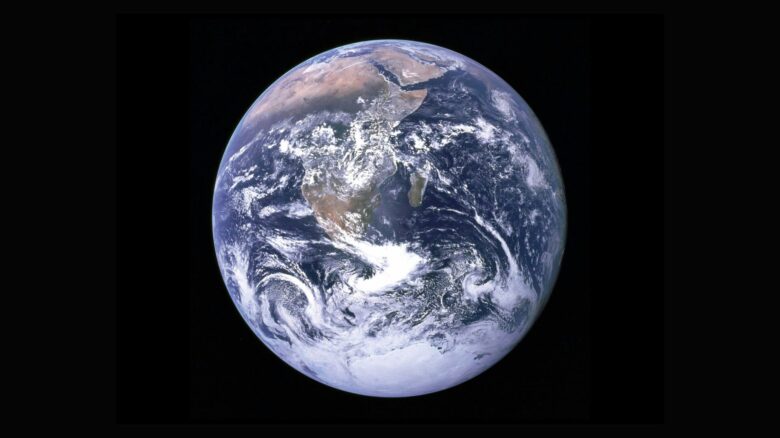In questo contributo, si cercherà di illustrare una serie di questioni determinante per il nostro tempo: anzitutto, i problemi relativi ai transfert di concetti tratti dalla fisica classica e dalla termodinamica nel campo dell’economia e della biologia. In effetti, ritengo che sia sempre necessario costruire delle epistemologie regionali a partire dalle quali costruire ponti o correlazioni e analogie, anziché fondare nuove discipline trasponendo concetti costruiti da altre scienze già costituite. Dunque, si mostrerà che i concetti fisici, per quanto utili, non sono sufficienti per comprendere l’evoluzione degli organismi viventi e il tempo storico (e non termodinamico) che caratterizza tanto l’economia, quanto la biologia. Per meglio cogliere dunque la questione dell’evoluzione verranno qui mobilizzati i concetti di preadattamento (o exattamento) e sovraccarico. Ciò consente di comprendere inoltre i limiti teorici della biologia molecolare che risulta incapace di cogliere i processi strutturanti l’evoluzione degli organismi.
Il mito dell’equilibrio in economia: il ruolo ambiguo della termodinamica
Il grande merito dell’opera di Nicholas Georgescu-Roegen1 è stato di criticare le equazioni di sistemi all’equilibrio utilizzate in economia portando l’attenzione alla termodinamica – cosa molto apprezzabile – mettendo il dito sul problema del fisicalismo in economia. Infatti, le equazioni in economia classica e neo-classica sono prese dalle dinamiche fisiche all’equilibrio. Tuttavia, la più semplice struttura economica è lontana dall’equilibrio, cioè essa è l’oggetto di un flusso di energia e materia, sia che noi scegliamo un’impresa, un Paese o la Terra intera, dove in quest’ultimo caso il flusso di energia che arriva dal sole è essenziale. Non è però la termodinamica che ci può guidare alla comprensione dell’economia: quest’ultima è una dinamica storica da analizzare nella nostra storia sociale e simbolica, ben aldilà delle teorie fisiche2, benché il riferimento alla termodinamica serva in modo definitivo e radicale alla critica di un’economia all’equilibrio, che ancora oggi risulta imperante: si è passati dalle equazioni di Léon Walras (1874) a quelle di Fokker-Planck (degli anni 1910), eccellenti equazioni per un sistema fisico all’equilibrio, le prime, con una componente probabilistica, le seconde. Dopo la crisi in borsa del 2008, ci spiegano che queste ultime ci permetteranno di giustificare il caso nei mercati borsistici. È incredibile di essere rimasti ancora fissati al feticcio dell’equilibrio: queste analisi, che riprendono un linguaggio che si pretende scientifico perché preso in prestito dalla fisica, inducono a gravissime deformazioni nelle analisi dei processi economici e sociali.
Si sa che le traiettorie all’equilibrio si fanno per integrazione di gradienti locali: cioè una geodetica, un percorso ottimale, seguito da una pietra che cade, possiamo descriverla grazie all’ottimo del gradiente locale. Non è dunque necessario conoscere la meta – questa è la rivoluzione di Lagrange e Hamilton: la luce, una pietra, un fiume che va al mare seguono il percorso più corto perché localmente il loro gradiente ha un’orientazione ottimale. Questo è l’assunto chiave delle economie all’equilibrio: a governare l’economia è soltanto l’ottimizzazione locale degli interessi locali, isolati. Questo è il senso profondo della spontaneità dei mercati. Questa visione funziona molto bene per l’inerte, ma nella concezione dei rapporti economici, sociali e ambientali, l’ottimizzazione locale dei profitti, che domina ancora oggi, sta per farci sbattere contro un muro, ed in particolare contro il muro globale del cambiamento climatico ed ecosistemico.
Dunque è più che benvenuta una critica a questa visione, anche se si fonda sulla termodinamica. Tuttavia, il sistema economico è anzitutto un sistema storico, mentre i sistemi termodinamici non hanno storia. Essi hanno un tempo irreversibile, ma la fiamma o l’uragano sono dello stesso tipo da 4 miliardi di anni, mentre la storia del vivente è molto cambiata, forme e funzioni sono profondamente cambiate. Pertanto, in questo contesto può essere utile utilizzare la termodinamica in economia, in una prospettiva critica, per evitare la visione dominante dell’ottimizzazione e dell’equilibrio, ma nel farlo è sempre necessaria grande prudenza.
L’irriducibilità della biologia alla fisica: tempo evolutivo vs. tempo irreversibile
Al fine di illustrare al meglio la specificità del tempo evolutivo, può essere utile riferirsi al processo biologico che Gould chiama ex-aptation (exadattamento)3. Si tratta dell’adattamento ex post di un organo per fare un’altra cosa: per esempio, le piume per lo scambio termico che diventa una componente essenziale del volo, o le podia di certi animali che diventeranno delle ali, oppure delle braccia negli esseri animali, o come 250 milioni di anni fa, la doppia mandibola dei Gnathostomata, cioè di certi vertebrati, che conduce allo sviluppo dell’orecchio interno. L’ex-adattamento è così ciò che crea un nuovo universo possibile, una nuova nicchia. Quando si hanno delle orecchie, l’udito cambia il nostro rapporto all’ecosistema.
L’exadattamento è stato articolato in modo informale da François Jacob, quando sostiene che l’evoluzione può essere pensata come l’utilizzo di un telaio di una vecchia sedia, sfruttato per fare la scatola di una radio. È un esempio eccellente: questa scatola non è evidentemente ottimale , tuttavia essa è molto comoda, poiché ci si può sedere per ascoltare la radio. Ciò accade in continuazione nel vivente, come la scatola della radio, le ali degli uccelli o del pipistrello, non sono ottimali, ma sono delle deformazioni (exadattamento) di forme che esistevano già, che assumono un altro uso e che per questo acquisiscono una nuova funzione.
Alcuni colleghi, operando un transfert teorico dalla fisica alla biologia, utilizzano per la morfogenesi, dei metodi d’ottimo, delle geodetiche nell’analisi della forma animale4, e persino nell’analisi delle traiettorie filogenetiche. E qui sbagliano perché appena le strutture biologiche di un organo o di un essere vivente diventano ottimali ciò comporta la morte della struttura biologica: la nozione di ottimo presuppone la stabilità di uno spazio nel quale si ha un ordine parziale, comparativo. In questo contesto, avere un ottimo, implica una rigidità fisica tale che essa non può che comportare l’incapacità di adattamento dell’organismo, dato che l’ecosistema è in perenne cambiamento. Per esempio è possibile analizzare tanto i nostri polmoni, quanto il nostro sistema vascolare, in termini frattali. Tuttavia, essi non sono esattamente frattali come sarebbe un cristallo fisico: è la diversità, l’irregolarità del polmone rispetto a tale forma fisica limitata, che lo rende adattivo alle condizioni cangevoli dell’atmosfera. La diversità del polmone, al contempo a livello individuale e nella specie, o in una popolazione, fornisce la stabilità di fronte al perenne cambiamento dell’ecosistema. Questa è una buona ragione per comprendere l’exadattamento come il risultato di una storia che apre a dei possibili, e che implica allontanarsi dalle analisi puramente fisiche delle strutture biologiche.
Si tratta dunque di introdurre una nozione essenziale nelle scienze evolutive: la durata bergsoniana. Non vi è che della durata. Non appena c’è del vivente, vi è un ritmo, dunque vi è una distanza tra due battimenti: il ritmo metabolico, il ritmo cardiaco, la respirazione. Sono queste durate che costruiscono il tempo del vivente. Se in fisica, da Aristotele ed Einstein, il tempo è ciò che si misura con l’orologio, nel vivente è molto più complesso: i ritmi, che sono dei numeri puri, che diventano delle frequenze quando si mettono in relazione alla durata della vita, esigono una nuova dimensione per essere rappresentati5. Ovviamente, c’è il tempo termodinamico, poiché vi sono numerosi processi termodinamici irreversibili, ma c’è anche il tempo storico, coordinamento cangiante di ritmi in e fra ecosistemi e, soprattuto, cambiamento dello spazio dei possibili biologici.
Ora, si pone la questione di sapere qualora sia opportuno aggiungere l’ulteriore dimensione temporale del tempo storico oltre a quella termodinamica dei fisici, poiché non si può avere una dimensione propria del vivente data matematicamente a priori. Infatti, il tempo dell’evoluzione è costituito dal processo stesso: il vivente comincia a organizzare il suo tempo interno con dei ritmi che corrispondono ad una costituzione del tempo locale. Vi è dunque del tempo locale per ogni organismo e la loro interazione in un ecosistema produce il tempo evolutivo. Non vi è regolarità ritmata nell’evoluzione. Non vi può essere un referente esterno che si possa porre come una dimensione propria data a priori del tempo evolutivo, poiché esso è costituito dalle interazioni e le deformazioni dei tempi locali dei ritmi di ogni organismo. Il tempo evolutivo è prodotto dal processo stesso: il tempo locale è espresso dai ritmi locali e dalla loro coordinazione, e il tempo globale di un ecosistema è prodotto dal processo evolutivo.
In questo senso, condivido l’analisi del tempo in termodinamica, che costituisce una componente essenziale e una dimensione pertinente anche per il tempo biologico. Tuttavia, questa componente o questa dimensione non è sufficiente in biologia, come ogni analisi in termini di entropia. La nozione di entropia come tale tratta alla termodinamica ha il tuo tempo irreversibile: questo tempo è sempre lì sullo sfondo nel vivente, poiché vi sono delle trasformazioni di energia, dunque vi è termodinamica, ma è necessario anche utilizzare un linguaggio molto più ricco che inglobi tali processi termodinamici. Per comprendere il vivente, bisogna anche utilizzare un altro linguaggio per il tempo propriamente biologico: i ritmi e il tempo globale storico, evolutivo, prodotto dai processi biologici6.
L’evoluzione del vivente contro il dogma della biologia molecolare: exadattamento, sovraccarico e exosomatizzazione
Sulla scia di Lewontin e di Gould, Mary-Jane West-Eberhard7 dimostra che la diversificazione e l’invenzione del nuovo nel corso dell’evoluzione si radicano spesso nella plasticità dello sviluppo. La stabilità di un nuovo percorso si costruisce sulla diversità permanente che si presenta durante l’ontogenesi a partire dall’embriogenesi. Considerando l’evoluzione del Gasterosteus aculeatus, West-Eberhard nota che tale pesce ha una certa diversità di ritmi metabolici. Ciò ha dato luogo ad una speciazione, secondo la quale un ritmo metabolico è più adatto ad una specie di superficie, mentre un altro ritmo è più adatto alle profondità marine. Vi è dunque un rapporto tra questa deformazione permanente che è al cuore dell’ontogenesi e la sua demarcazione da parte di episodi evolutivi che danno luogo alla speciazione evolutiva, cioè alla mobilità verso un’altra nicchia ecosistemica.
Tali vincoli ecosistemici che plasmano l’evoluzione, e che sono plasmati dall’evoluzione, cioè dalla costituzione permanente di nicchie, rendono possibili delle strutture di organismi e di fenotipi che non esistevano precedentemente. Ecco la questione fondamentale: il cambiamento dello spazio di possibili, ciò che in fisica si chiama spazio di fasi, cioè l’insieme di osservabili e parametri pertinenti. In sintesi, questi spazi di fasi non sono stabili – come è invece presupposto in ogni teorica fisica – ma cambiano all’interno stesso della teorizzazione dell’evoluzione biologica. L’exadattamento è la testimonianza di questa costituzione di un nuovo possibile, di un nuovo organismo, una nuova nicchia, assieme ai nuovi osservabili e parametri pertinenti.
A questo punto, vale aggiungere alla nozione di exadattamento di Gould, la nozione di sovraccarico. Un organo è ‘sovraccarico’ quando continua ad avere la sua funzione, mentre si adatta per averne un’altra8. Gli organi più sovraccarichi nel corso dell’evoluzione sono tipicamente il cervello e le mani dell’uomo. Alcuni sovraccaricano anche il naso con gli occhiali, altri le orecchie mettendo orecchini e così via. La mano è un luogo di sovraccarico incredibile: l’utilizziamo persino per suonare il pianoforte! Questi sovraccarichi possono modificare l’organo stesso! Come è il caso paradigmatico del cervello: una struttura neuronale che si modifica con l’attività. Così, un caso ben conosciuto nella neurofisiologia moderna è quello del violinista, la cui attività modifica strutturalmente le connessioni sinaptiche e lo spessore stesso delle connessioni in alcune regioni del cervello.
Il sovraccarico degli organi avviene sempre più attraverso oggetti artificiali, organi tecnici, cioè all’interno di un ambiente costituito da exosomatizzazioni, quali descritte da Bernard Stiegler9, che ci obbliga a considerare il ruolo dell’ambiente nell’evoluzione del vivente contro il ‘dogma centrale’ della biologia molecolare ancora dominante, ad esclusione di ogni attenzione all’epigenetica. Infatti, è necessario riconoscere che vi è ancora oggi un’egemonia totale del geno-centrismo: è sufficiente seguire ciò che è successo nel dibattito attorno ai vaccini al RNA e il ruolo che hanno queste nuove tecniche di editing. Sempre più urgente risulta in Europa il problema posto dagli OGM, poiché con questa nuova tecnica CrisprCas9, ci viene detto che queste manipolazioni sono naturali e che si faranno OGM «sani». Ma cosa sono gli OGM? La filiazione diretta del dogma centrale della biologia molecolare: si tratta di pilotare esattamente l’organismo nell’ecosistema modificandone i programmi genetici, come ci spiega Jennifer Doudna, recente premio Nobel in chimica nel 2020 – controllare l’evoluzione, scrive10.
In definitiva, Jennifer Doudna incentra il suo lavoro sul dogma centrale11: lei ci spiega che è possibile, oltre che controllare l’evoluzione, anche curare tutte le malattie12. A oggi, Jennifer Doudna è la candidata più probabile per la presidenza del National Institutes of Health (NIH) americano che dispone di 37 miliardi di budget annui: si tratta della più grande istituzione di ricerca biomedica al mondo. Ricordiamo inoltre che di fronte alle difficoltà riscontrate durante la pandemia, come di fronte alle inquietudini eco-sistemiche, coloro che sostengono questo ‘dogma’ hanno adottato un tono messianico. Ed è così che i seguaci più entusiasti di J. Doudna, ci promettono di far adattare l’uomo ai cambiamenti ecosistemici modificandone il DNA13. Analogamente, «elimineremo tutti i virus delle vie aeree superiori» promette un progetto finanziato da Bill Gates. Un’assurdità, dato che il 99%, o più, dei batteri e dei virus sono simbiotici o indifferenti. Per dirlo altrimenti, i (grandi) organismi incompatibili con più dell’1% dei batteri o dei virus sono morti. Noi siamo ancora a questo livello di miti scientisti, e di fronte alla crisi, il messianismo del «techno-fix [tecno-soluzionismo]»14 ridona incredibile vitalità a questa pseudo-cultura, questa pseudo-scienza, capace tuttavia di mobilizzare ingenti quantità di finanziamenti e tecnologie senza scienza15. E tutto ciò permette di non occuparsi delle cause del cambiamento ecosistemico o delle epidemie, sempre più numerose, come già denunciato da tempo16.
Note
- N. Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1971.
- R. Koppl, S. Kauffman, G. Longo e T. Felin, Economy for a Creative World, in “Journal of Institutional Economics”, vol. 11, n. 1, 2015, pp. 1-31.
- S.J. Gould, The Structure of Evolutionary Theory, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2002.
- V. Fleury e R. Gordon, Coupling of Growth Differentiation and Morphogenesis, and Integrated Approach to Design in Embryogenesis, in L. Swan, R. Gordon e J. Seckbach (a cura di), Origin of Design in Nature. A Fresh, Interdisciplinary Look at How Design Emerges in Complex Systems, Especially Life, Springer Verlag, Berlin 2011, pp. 385-428.
- G. Longo e M. Montévil, Perspectives on Organisms: Biological Time, Symmetries and Singularities, Springer, Dordrecht 2014.
- G. Longo, Confusing biological twins and atom clocks. Today’s ecological relevance of Bergson-Einstein debate on time, in A. Campo e S. Gozzano (a cura di), Einstein vs. Bergson. An enduring quarrel of time, Walther de Gruyter, Berlin 2021, pp. 375-406.
- M-J. West-Eberhard, Developmental Plasticity and Evolution, Oxford University Press, New York 2003.
- G. Longo, How Future Depends on Past Histories and Rare Events in Systems of Life, in Foundations of Science, vol. 23, n. 6, 2017, pp. 443-474.
- E. Toffoletto, Stiegler e la nuova critica dell’economia politica – parte 1, in “Equilibri Magazine. Rivista per lo sviluppo sostenibile”, 26 settembre 2022, https://equilibrimagazine.it/economia/2022/09/26/bernard-stiegler-la-nuova-critica-economia-politica-prima-parte/.
- J. Doudna e S. Sternberg, A crack in Creation. The new power to control evolution, Bodley Head, London 2017.
- G. Longo, Programming Evolution: A Crack in Science. A Review of the Book by Jennifer A. Doudna and Samuel H. Sternberg “A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control Evolution”, in “Organisms. Journal of Biological Sciences”, vol. 5, n. 1, 2021, pp. 5-16.
- J. Doudna, The CRISPR Health Revolution, in “Frontiers Forum”, 31 marzo 2022, https://www.youtube.com/watch?v=w.
rrHc_avAxY. - W. Isaacson, The Code Breaker: Jennifer Doudna. Gene Editing, and the Future of the Human Race, Simon & Schuster, New York 2021.
- C. Petit e G. Longo, The Pandemic and the “Techno-fix”, in “Organisms. Journal of Biological Sciences”, vol. 6, n. 1, 2023, pp. 23-39.
- G. Longo, Matematica e senso, Mimesis, Milano 2022 e G. Longo, Le cauchemar de Prométhée. Les sciences et leurs limites, PUF, Paris 2023.
- S. Morand, M. Foguié (a cura di), Émergence de maladies infectieuses. Risques et enjeux de société. Editions Quae, Paris 2016.