Danilo Zagaria, biologo e divulgatore scientifico, ci accompagna con In alto mare. Paperelle, ecologia, Antropocene (add editore, 2022, €16,00) in un percorso narrativo e scientifico, con l’intento di far emergere le profonde connessioni fra l’uomo e gli ecosistemi marini. Il libro è diviso in quattro grandi capitoli — il mare e la plastica, il mare e la pesca, il futuro dell’Artico e il cambiamento dei mari — che costruiscono un mosaico di storie, dati, immagini e riflessioni.
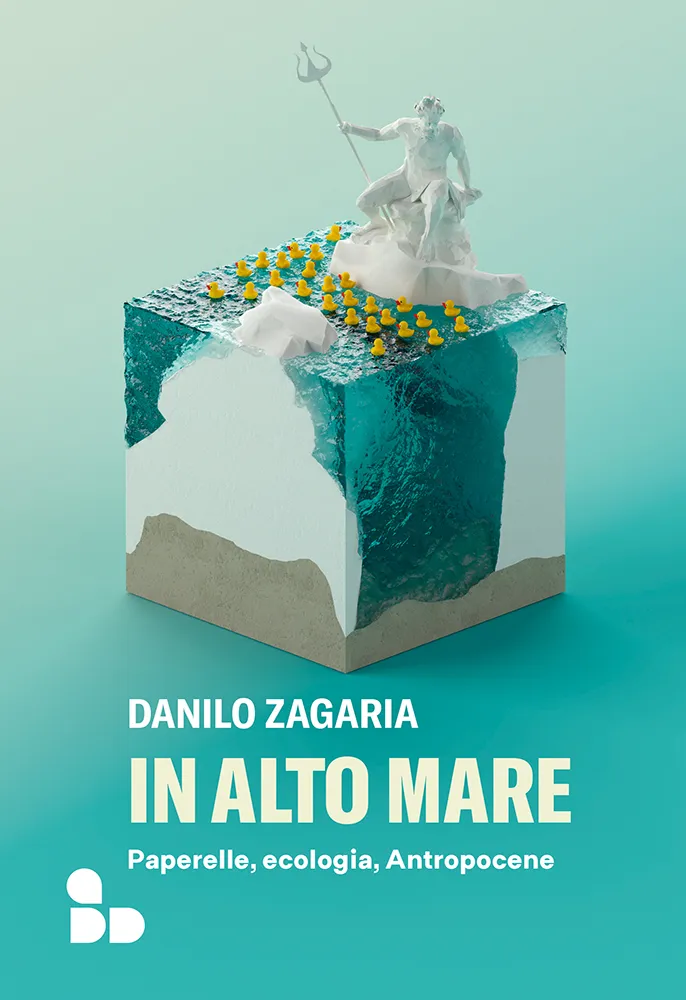
L’opera si apre con un episodio divenuto celebre nella letteratura ecologista: la caduta in mare, nel 1992, di migliaia di paperelle di plastica dal cargo Ever Laurel. Quell’incidente, all’apparenza curioso, è invece emblema della nostra epoca, poiché «le paperelle e gli altri animali, infatti, sono una delle tante prove del nostro impatto sugli ecosistemi, in particolare quelli marini». Quei piccoli oggetti, galleggiando per decenni, hanno reso visibile l’onnipresenza della plastica nei cicli biogeochimici terrestri.
Zagaria intreccia divulgazione scientifica e narrazione letteraria. La sua voce è chiara e accessibile. L’introduzione chiarisce che l’ecologia non riguarda solo «animali, foreste, insetti, deserti, mari e fiumi, ghiacciai e via dicendo, ma anche tutti gli effetti che le nostre azioni hanno su specie ed ecosistemi». È un invito a riconoscere l’Antropocene, l’ ‘epoca dell’uomo’, come cornice imprescindibile delle nostre vite.
Nel capitolo dedicato alla plastica, l’autore mostra come gli oggetti quotidiani siano intrecciati con tempi geologici e con processi ecologici che ci sfuggono. Scrive: «Dovremmo invece provare a immaginare la vita intera dell’oggetto: non soltanto che cosa gli succederà dopo che lo avremo buttato, ma anche che cosa è successo prima che fosse prodotto». La riflessione, quasi filosofica, spinge il lettore a guardare ogni manufatto come condensazione di storie millenarie, non come prodotto effimero da consumare.
La parte sul mare e la pesca affronta invece uno dei nodi centrali della sostenibilità. Zagaria ricorda che «si può pescare senza svuotare i mari e portare all’estinzione le specie di cui ci cibiamo», ma sottolinea anche l’insostenibilità di un consumo crescente e illimitato: «non possiamo illuderci che ci sia pesce per tutti, in grandi quantità e in eterno. Se vogliamo vivere in modo sostenibile, dobbiamo seguire il primo principio della sostenibilità: il consumo va ridotto». Qui la scrittura diventa più urgente, quasi etica, perché ci pone davanti alla necessità di ripensare i nostri stili alimentari.
La sezione sull’Artico è fra le più suggestive e inquietanti. Attraverso storie di popoli indigeni e di scienziati, Zagaria mostra l’intreccio fra geopolitica, cambiamenti climatici e sopravvivenza. «Il nuovo interesse per il nord […] è una potenziale fonte di minaccia per la loro sopravvivenza», scrive a proposito delle comunità sami, minacciate non solo dal riscaldamento globale ma anche dalle mire delle multinazionali. Il racconto si fa corale, alternando la fragilità degli ecosistemi artici all’avidità delle potenze mondiali che vedono nello scioglimento dei ghiacci nuove rotte e nuove risorse da sfruttare.
Nell’ultima parte, Cambiare il mare, l’autore porta la riflessione al cuore dell’Antropocene: i mari diventano più caldi, più acidi, più alti, e con essi mutano le nostre vite. Il paragone con la pandemia di Covid-19 è illuminante: «Le sfide che molti problemi ambientali […] ci pongono sono simili a quelle poste dal Covid-19. […] Climate change potrebbe voler significare: devi abituarti alle auto elettriche […] quel pesce che ti piaceva tanto non lo potrai più mangiare». È un invito a riconoscere che la crisi ecologica non è qualcosa di esterno a noi, ma un processo che ridisegna quotidianità, desideri, possibilità.
Lo stile di Zagaria mescola divulgazione, ironia, e un uso frequente di esempi letterari e cinematografici. Il libro non vuole solo informare, ma anche stimolare l’immaginazione: «Gli stessi problemi ambientali, climate change in primis, sono quasi invisibili. Pertanto, per risolverli occorre prima di tutto immaginarli, studiarli e visitarli». È questa forse la lezione più preziosa del volume: per affrontare la crisi planetaria serve un esercizio di immaginazione collettiva, capace di rendere visibile ciò che di solito resta invisibile.
In alto mare è quindi un testo che riesce a unire la precisione del dato scientifico alla potenza della narrazione. Non propone facili soluzioni, ma invita a cambiare prospettiva, a guardare i mari e la Terra con occhi diversi. È un libro che ricorda al lettore come il destino degli oceani e quello dell’umanità siano indissolubilmente intrecciati.