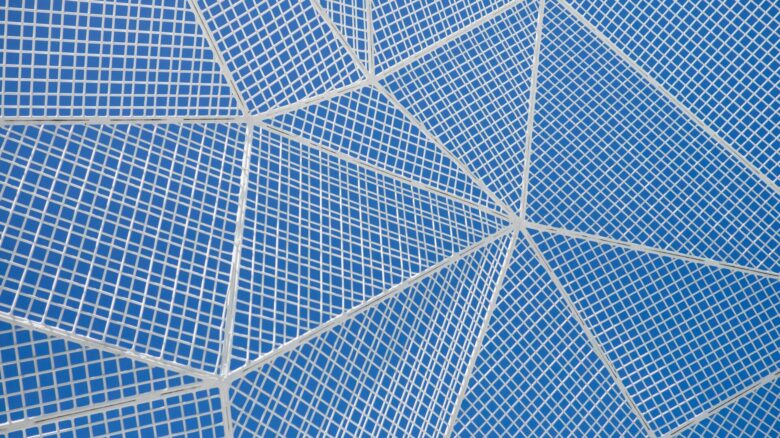L’Europa corre verso un futuro più pulito e a zero emissioni. Pannelli solari, turbine eoliche, auto elettriche: simboli di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Ma c’è un lato meno visibile – e molto meno pulito – di questa transizione: si trova sotto i nostri piedi.
Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, servono materie prime come litio, cobalto, nichel e terre rare, note come metalli per la transizione energetica (Energy Transition Metals, o ETM). Sono componenti fondamentali per batterie, magneti, motori elettrici e sistemi per le energie rinnovabili.
Il problema? L’Europa ne possiede pochi, ne ricicla ancora meno, e l’estrazione è tutt’altro che innocua da un punto di vista ambientale.
Uno studio recente di Andrea Bastianin, Chiara F. Del Bo e Luqman Shamsudin mette in luce con questo dilemma. Mappando per la prima volta i costi ambientali dell’attività mineraria legata alla transizione verde in Europa, gli autori stimano quanta CO₂ verrebbe rilasciata per estrarre i metalli necessari. I risultati illustrano il dilemma tra risorse e ambiente di fronte al quale si trovano i responsabili delle politiche ambientali ed industriali.
Una dipendenza difficile da spezzare
L’Unione Europea importa oggi circa il 75% delle sue materie prime critiche. Per alcuni metalli, come grafite o terre rare, la dipendenza è vicina al 100%. Questi materiali provengono spesso da Paesi instabili o con scarse tutele ambientali, aumentando i rischi economici, geopolitici e reputazionali.
Per ridurre la vulnerabilità e garantire forniture più sicure, l’Europa sta valutando la possibilità di aumentare l’estrazione interna. Ad esempio, il rapporto Draghi sul futuro della competitività Europea dedica un capitolo al tema dei materiali critici e propone una accelerazione nella apertura o riapertura delle miniere interne. Ma aprire nuove miniere in casa ha un costo, soprattutto ambientale.
Quando la transizione verde emette CO₂
Estrarre metalli non è un processo ‘pulito’. Richiede energia, consumo di acqua, uso di sostanze chimiche e spesso comporta la distruzione di ecosistemi. Paradossalmente, per produrre tecnologie che riducono le emissioni, potremmo doverne generare di nuove.
Per quantificare questi impatti, lo studio utilizza l’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Impact Assessment – LCIA), concentrandosi sul potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential – GWP), cioè sulla quantità di CO₂ equivalente emessa lungo il processo estrattivo.
I ricercatori traducono poi questi impatti fisici in costi monetari, rendendo più comprensibile per decisori pubblici e opinione pubblica il ‘prezzo’ della transizione.
Il risultato? Se tutti i progetti minerari mappati venissero sfruttati appieno, le emissioni associate all’estrazione di ETM in Europa equivarrebbero all’11% delle emissioni totali di CO₂ dell’UE nel 2021. In termini economici, il costo ambientale sarebbe compreso tra lo 0,07% e l’1,79% del PIL, a seconda del Paese.
Un peso distribuito in modo diseguale
Il costo ambientale della transizione non è equamente distribuito. Alcuni Paesi e regioni sopporterebbero un peso molto maggiore di altri.
I ‘punti caldi’ dell’attività mineraria in Europa sono localizzati soprattutto nei Paesi nordici (Finlandia e Svezia), in Polonia, in Groenlandia e in Georgia. L’Europa centrale e occidentale, invece, ospita pochissimi progetti minerari.
La Finlandia, ad esempio, potrebbe affrontare un impatto ambientale pari a oltre il 9% del suo PIL. Anche la Svezia e la Georgia mostrano valori elevati. Al contrario, Paesi come Francia e Repubblica Ceca risultano quasi indenni, semplicemente perché non dispongono di grandi riserve di ETM.
Anche a livello regionale le differenze sono marcate: la regione finlandese dell’Etelä-Suomi domina nella produzione di tantalio, mentre la Svezia settentrionale è ricca di grafite e vanadio. La Groenlandia possiede riserve preziose di terre rare, platino e niobio.
Questa concentrazione geografica solleva questioni politiche delicate: è giusto che alcune regioni paghino un prezzo ambientale per il beneficio collettivo dell’UE? E in tal caso, come dovrebbero essere compensate?
Gestire l’incertezza per evitare errori
Le stime sull’impatto della espansione del comparto minerario dipendono da molte variabili: quantità estratta, efficienza tecnologica, evoluzione dei prezzi, vincoli ambientali futuri. Per tenere conto di queste incertezze, lo studio utilizza un metodo chiamato simulazione Monte Carlo: invece di fornire un’unica stima, genera migliaia di scenari possibili.
Questo approccio permette di valutare non solo quali aree hanno il maggiore impatto previsto, ma anche dove l’incertezza è più elevata. Ad esempio, la Groenlandia – pur essendo il principale ‘hotspot’ minerario – presenta una gamma molto ampia di possibili impatti ambientali, proprio perché ancora poco sviluppata.
Al contrario, Finlandia e Svezia mostrano stime più stabili e affidabili, il che le rende territori meno rischiosi da un punto di vista decisionale.
La lezione è chiara: servono politiche flessibili, basate su dati aggiornati e consapevoli delle incertezze. Agire in fretta senza considerare i possibili scenari potrebbe portare a decisioni costose e dannose nel lungo periodo.
Come scavare in modo responsabile
Se l’Europa deciderà di aumentare l’estrazione interna di materie prime, dovrà farlo con cautela. Lo studio suggerisce diverse strategie:
- Concentrare gli sforzi sui materiali e sulle aree a minore impatto. Alcuni metalli, come il platino o l’argento, hanno un costo ambientale molto più elevato rispetto a ferro o zinco. Prioritizzare le estrazioni meno impattanti potrebbe ridurre le emissioni complessive.
- Puntare seriamente sul riciclo. Attualmente, i tassi di riciclo per molti ETM sono molto bassi. Migliorare la filiera del recupero di materiali potrebbe ridurre la necessità di nuove estrazioni.
- Stringere partnership con Paesi affidabili fuori dall’UE, come la Groenlandia o la Georgia, vincolandole a standard ambientali e sociali elevati.
- Adottare politiche regionali differenziate. Le scelte non possono basarsi solo su medie nazionali. Le regioni coinvolte devono essere protagoniste della pianificazione e della valutazione dei costi-benefici.
- Coinvolgere le comunità locali. Le miniere possono generare occupazione, ma anche conflitti e degrado ambientale. Serve trasparenza, partecipazione e un forte senso di equità.
Conclusione: la terra sotto i nostri piedi conta
Questo studio lancia un messaggio semplice: per affrontare la crisi climatica abbiamo bisogno di metalli. Ma l’estrazione non è mai neutra. Ogni tonnellata di litio o cobalto che estraiamo genera un costo in CO₂, consumo di suolo e potenziali tensioni sociali.
Se vogliamo che la transizione energetica sia davvero sostenibile, dobbiamo guardare non solo a ciò che costruiamo in superficie, ma anche a ciò che distruggiamo sotto terra o nei fondali marini.
L’Europa ha oggi una scelta difficile: continuare a importare materie prime da Paesi terzi, o quando possibile estrarle in casa propria accettandone i costi. In entrambi i casi, la chiave è decidere con responsabilità, dati affidabili e una visione di lungo termine.
Perché la corsa alla transizione verde non deve diventare una nuova corsa verso il degrado ambientale. La sostenibilità comincia proprio da qui: dalla terra che calpestiamo ogni giorno.