In un’epoca in cui ogni crisi sembra trasformarsi in merce — dall’ambiente alla salute, dalla giustizia sociale all’acqua — Sete di Filippo Menga (Ponte alle Grazie, 2024, € 20,00) è un libro che arriva insieme come un pugno allo stomaco e una boccata d’aria fresca. Il volume è una riflessione profonda sullo stato della ‘crisi idrica globale’, che l’autore scompone e smonta con gli strumenti della geografia politica e dell’ecologia critica corredati da un’ironia tagliente.
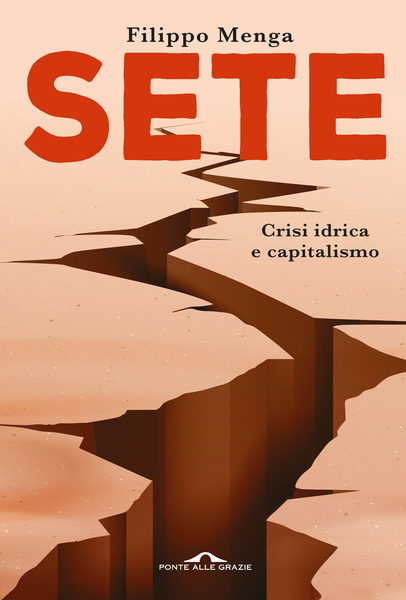
Fin dalle prime righe, Menga ci catapulta nella realtà concreta della crisi idrica europea, con l’immagine simbolica delle navi cisterna che nel 2024 partono da Valencia per rifornire Barcellona, dove si è entrati nella fase di ‘emergenza 1’ e il razionamento è già iniziato. È un modo efficace per ricordarci che non si tratta più solo di scenari apocalittici da Sud globale: l’acqua manca anche nel cuore dell’Europa, anche nei paesi ricchi, anche nelle nostre case.
«La crisi ambientale, e con essa quella idrica, non è più qualcosa che si potrà verificare in un futuro lontano e imprecisato. La crisi è adesso, ed è imprevedibile».
Il vero bersaglio polemico del libro è il capitalismo. Ma Menga non si limita a una condanna generica: mostra con chiarezza come il sistema economico dominante abbia incorporato la gestione della crisi idrica all’interno delle sue logiche di profitto, consumo e greenwashing.
«Scrivere una critica del capitalismo non vuol dire necessariamente scrivere un libro ‘di sinistra’. Raccontare il capitalismo significa raccontare quella che è, senza ombra di dubbio, la principale forza motrice a livello economico, politico, sociale e culturale del nostro tempo».
Menga sostiene che la crisi idrica non è una semplice conseguenza esterna del capitalismo, ma una sua produzione interna. La scarsità d’acqua, infatti, è funzionale all’espansione della frontiera mercificata. Seguendo l’ecologo politico Jason Moore, l’autore afferma che il capitalismo ha bisogno di nuove risorse da sfruttare per sopravvivere: il problema non è l’acqua che finisce, ma chi la controlla, la vende, la imbottiglia, la rende oggetto di scambio, di profitto, di branding.
Uno dei temi più forti del libro è la critica alla ‘responsabilizzazione dell’individuo’, ossia alla retorica secondo cui tocca a ciascuno di noi risolvere il problema con piccoli gesti quotidiani. Ci viene costantemente ripetuto che il problema risiede nelle nostre abitudini: docce troppo lunghe, lavastoviglie non abbastanza ‘eco’, rubinetti lasciati aperti mentre ci laviamo i denti. Menga cita spot come quello di Colgate al Super Bowl, che invita a chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, o le campagne di Finish e National Geographic che ci spingono a usare la lavastoviglie con criterio.
«È possibile che sia l’azione individuale a risolvere un problema strutturale e sistemico? […] Dovrei pensare a me stesso solo come a un consumatore?».
Secondo l’autore, questo tipo di comunicazione non ha nulla a che fare con la reale soluzione della crisi idrica, ma serve piuttosto a spostare la responsabilità dalle strutture economiche e politiche sulle spalle dei cittadini-consumatori.
Il libro entra poi nel vivo della critica al cosiddetto filantrocapitalismo, ossia quella forma ibrida in cui la filantropia, il marketing e il capitalismo si fondono per creare una solidarietà ‘di mercato’. Un caso emblematico è quello dello spot Stella Artois + Water.org, in cui Matt Damon promette che, acquistando un calice da birra, si può fornire acqua a un milione di persone.
«Un calice con il logo Stella Artois può cambiare le cose, ci dice Damon: ‘Se anche solo l’1% di voi che state guardando ne acquistasse uno, potremmo fornire acqua pulita a un milione di persone per cinque anni’».
Questa promessa, per quanto nobile nelle intenzioni, risulta paradossale nel contesto ipercommerciale del Super Bowl. Menga ne sottolinea l’ambiguità: quanto è efficace una campagna del genere? E soprattutto, chi ne trae veramente beneficio?
Menga non tralascia neppure il tema spinoso dell’acqua in bottiglia. L’Italia, scrive, è il primo consumatore in Europa e il secondo nel mondo dopo il Messico. Aziende come Nestlé Waters hanno costruito veri e propri imperi sulla mercificazione dell’acqua. Eppure, queste stesse aziende si presentano come paladine della sostenibilità e della salvaguardia ambientale.
Il libro mette poi a nudo le contraddizioni delle ‘corporate social responsibility’ legate all’acqua, mostrando come spesso le campagne ecologiste servano più a rafforzare l’immagine aziendale che a generare un impatto reale. Il greenwashing diventa quindi un meccanismo fondamentale di legittimazione del profitto.
Uno degli aspetti più brillanti del libro è l’analisi di due casi-studio molto diversi tra loro ma uniti da una logica comune: la crisi idrica di Città del Capo nel 2018 e quella di Mexicali, in Messico. Nel primo caso, l’intero discorso pubblico si è concentrato sul cosiddetto ‘Day Zero’, il giorno nel quale si sarebbe rimasti senz’acqua, ignorando però le disuguaglianze strutturali che facevano sì che alcuni (i più poveri) soffrissero da anni di scarsità idrica, mentre altri continuavano a riempire piscine.
«La narrazione del ‘Day Zero’ ha tolto l’onere della responsabilità dalle spalle della città e lo ha spostato su quelle dei cittadini».
Nel secondo caso, a Mexicali, una protesta popolare è riuscita a bloccare la costruzione di un mega-birrificio di Constellation Brands, che avrebbe sfruttato una risorsa già scarsa per esportare birra negli Stati Uniti. Qui, la crisi non era solo ambientale, ma anche geopolitica: un caso di colonialismo economico a base idrica.
L’espressione ‘crisi idrica globale’ è in sé problematica. L’acqua non è una risorsa globale come il petrolio o il gas: è transitoria, pesante, difficile da trasportare. È fondamentalmente locale, e la sua distribuzione dipende da dinamiche socioeconomiche complesse. Tuttavia, il discorso globale sulla crisi ha preso piede, alimentato da esperti, ONG, agenzie ONU, aziende e fondazioni.
Il rischio, avverte l’autore, è quello di depoliticizzare il problema, riducendolo a una questione di indicatori, benchmark e buone pratiche, senza mai mettere in discussione i rapporti di potere e le logiche di sfruttamento che lo generano.
Nonostante la profondità teorica, Sete è scritto con uno stile accessibile, narrativo e coinvolgente. Menga utilizza esempi concreti, racconti personali, citazioni efficaci e analisi dettagliate.
Sete non propone soluzioni facili, non si rifugia nel tecnicismo o nel moralismo. Piuttosto, è un invito alla consapevolezza e all’azione politica. L’acqua, ci ricorda Menga, non è solo una risorsa naturale: è un bene comune, un diritto umano, un terreno di lotta. E non può essere lasciata nelle mani del mercato, della filantropia di facciata o della coscienza ecologista dei VIP.
È tempo di ripensare il modo in cui viviamo, consumiamo e ci relazioniamo con il pianeta. E per farlo, bisogna partire proprio da ciò che ci tiene in vita: l’acqua.