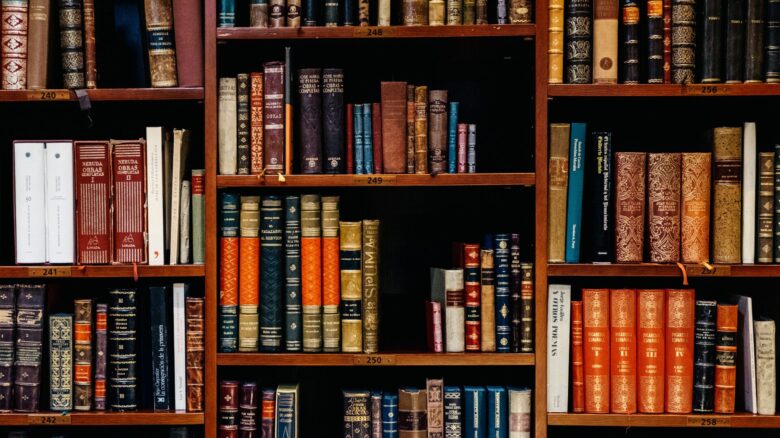Solamente chi sente in sé quel senso di povertà, di vuoto lucente, è in grado di incamminarsi, di accogliere dentro di sé il mondo e di esserne accolto. «Se mi mancasse il sentimento del mondo, non potrei più scrivere nemmeno mezza lettera dell’alfabeto, né comporre alcunché in versi o prosa. Senza passeggiate sarei morto e da tempo avrei dovuto rinunciare alla mia professione, che amo appassionatamente». Confessa candidamente Robert Walser nel suo racconto più celebre, La passeggiata.
Un’altra figura emblematica della poesia del Novecento, García Lorca, ci guida in questo poetare con gli elementi, con il fuoco, sotto il cielo: «La virtù magica del componimento poetico consiste nell’essere sempre intriso di duende per battezzare con acqua scura tutti quelli che lo guardano, perché con duende è più facile amare, comprendere, ed è certo essere amati, essere compresi, e questa lotta per l’espressione e per la comunicazione dell’espressione acquista a volte in poesia caratteri mortali».
García Lorca ci suggerisce che la vera lotta per il poeta non è con l’angelo, o con la musa (figure provenienti da fuori) ma con il duende, spirito della terra, «discendente di quell’allegrissimo demone di Socrate, marmo e sale, che lo graffò indignato il giorno in cui bevve la cicuta», e «che infiammò il cuore di Nietzsche» provenendo da dentro: «il duende, al contrario, bisogna risvegliarlo nelle più recondite stanze del sangue. E bisogna respingere l’angelo, e sferrare un calcio alla musa, e perdere la paura del sorriso di violette che emana la poesia del Settecento e del gran telescopio sui cui cristalli si assopisce la musa, malata di limiti. La vera lotta è con il duende».
La poesia lotta nell’aperto, e ogni passo, che batte sulla terra, richiama dentro di sé il mondo, risvegliandolo: annunciandolo come creatura vivente. E l’aura del mondo risponde guardandoci. E lo sguardo del mondo precede il nostro guardare. Ma se i mortali, gli umani, dimenticano di considerare il mondo, la terra come creatura vivente, e la straziano, come carne morta, allora il mondo diviene cieco, insensibile ai più, esso si ritrae dentro una tana. E non esce più preferendo lasciarsi morire. Ma la morte del mondo è la morte dell’umano. I poeti, coloro che camminano in povertà (nella gratuità) annunciano la morte del mondo – ossia la nostra incapacità di sentire il mondo, poiché esso continua a vivere malgré-nous – nella modernità.
I poeti lasciano cadere l’aura, come segno ineludibile, della necessità di un nuovo (diverso) avvicinamento al mondo, al suo mistero, cercando di riapprendere ad ascoltarlo come creatura vivente.
«L’esperienza dell’aura riposa quindi sul trasferimento di una forma di reazione normale nella società umana al rapporto dell’inanimato o della natura con l’uomo. Chi è guardato o si crede guardato alza gli occhi. Avvertire l’aura di una cosa significa dotarla della capacità di guardare». Walter Benjamin
Benjamin nei suoi mirabili scritti su Baudelaire indica un nucleo primordiale nell’opera del poeta, che ancora – e sempre di più – ci riguarda.
Se l’aura è lo sguardo che noi diamo al mondo (alle creature), alle cose, e che riceviamo da esse, siamo ora giunti (da quasi due secoli) in un punto dove questa reciprocità ha cessato di esistere.
La perdita dell’aura è la perdita del sacro. La miseria dell’assenza di miseria.
«Allora il tempo misero non si rende neppure più conto della propria indigenza. Questa incapacità per cui la stessa indigenza della povertà è dimenticata, è la vera e propria povertà del tempo. La povertà viene oscurata completamente quando appare solo più come bisogno da soddisfare». Martin Heidegger
Qui Benjamin e Heidegger, si avvicinano, ognuno dai propri territori, a una visione della poesia dove il poeta è il più arrischiante, colui che getta l’aureola nel fango.
Baudelaire nel suo citatissimo scritto ‘marginale’ sulla perdita dell’aureola, che cade nel fango, segna l’ingresso del poeta nella modernità: «l’aureola, in un movimento brusco, mi è scivolata dal capo ed è caduta nel fango del selciato. Non ho avuto il coraggio di raccoglierla».
Egli coglie in anticipo la modernità che avanza con la sua falce e miete il passato e l’inghiotte, divorando al contempo il presente. L’avvenire è macerie.
La figura del flâneur mutuato da Edgar Allan Poe e resa archetipale da Baudelaire (e da Benjamin interprete di Baudelaire) dice già l’impossibilità della flânerie. Camminare sognanti senza meta, non è permesso in città, Baudelaire ne coglierà le ultime avvisaglie, gli ultimi sussulti.
La passeggiata ‘inutile’ e meravigliosa sarà nuovamente ripensata dal Novecento (Joyce, Walser, Cortázar).
La città moderna uccide i poeti: la grata di rue de la Vieille-Lanterne dove Nerval decide di terminare il suo errare, il ponte Mirabeau sulla Senna da dove Celan si immerge nell’infinito, ponendo fine alla sua vita. Così come uccide coloro che studiano la lingua da sognatori (Roland Barthes, Luca Serianni).
I poeti, i più arrischianti, perché rischiano il linguaggio, e nel linguaggio la parola, non devono raccogliere l’aureola caduta nel fango, ma neppure santificare il fango (Bukowski, il Gruppo 63).
Essi devono riconsacrare il mondo, salvarlo nella parola.
«Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c’è niente di naturale nella natura, ragazzo mio, tienilo bene in mente. Quando la natura ti sembrerà naturale, tutto sarà finito – e comincerà qualcos’altro», dice il centauro Chirone nella Medea di Pasolini.
I poeti devono rompere, oltrepassare, annullare, l’assurda frontiera presidiata da storici, sociologi, linguisti, poeti e artisti provvisti di aureola saldamente incastrata sul capo come un elmetto, la frontiera che divide il reale dall’immaginario (dall’Immaginale). La parola dal nome. Il corpo dall’anima.
Da Descartes in poi l’occidente ha schiacciato e annientato la propria anima dentro questa divisione (res cogitans e res extensa): rappresentazione.
Il poeta, povero di parole, povero di mondo, spogliandosi del linguaggio dei fini, si avvicina alla fonte sacra della lingua. La ritrova in ogni parola. E benedicendo il nome benedice la cosa: casa dell’essere.
L’immaginazione è l’oceano dove nuota la parola. Essa è senza confini. È l’anima di ciò che definiamo – impropriamente – realtà. L’altro lato della natura: soprannaturale (l’altra natura, la natura della natura).
«L’interiorizzazione rimemorativa è il capovolgersi della separazione in accesso al più ampio Cerchio dell’Aperto». Heidegger
I poeti abitano l’immaginazione:
«Questo reale – o realtà –, non è che un gran sogno, e la sua realtà (se si escludono i materiali di cui si serve per manifestarsi, del resto completamente vuoti, quindi immateriali), è pura Immaginazione. E questa Immaginazione non è nostra – di ogni essere vivente –, ma piuttosto ogni essere vivente viene da questa Immaginazione». Anna Maria Ortese
Il poeta rovescia l’abisso della perdita di senso del mondo e fa, lascia che questa perdita abbia un ‘nuovo’ senso: abbia di nuovo senso.
L’abisso orrendo della quotidianità è infranto dal poeta, animale, bestia da stile, con gli artigli della parola, lacerando il giorno in brandelli di istanti. Smembrato il giorno la parola fiorisce in istanti irripetibili (la mémoire involontaire, la Recherche di Proust).
«L’importante è che le correspondances fissano un concetto di esperienza che ritiene in sé elementi cultuali». Benjamin
Le correspondances baudelairiane sono, come ci ricorda Benjamin, questi istanti rubati al tempo ed elevati come templi nel deserto della lingua, come preghiere in un tempo di naufragio.
L’immaginazione poetica apre la lingua – come si apre un frutto – a orizzonti inauditi.
L’infinito abita ogni parola, per chi ha la forza di varcare l’abisso più stretto (il più difficile da riconoscere). «C’è un abisso tra il prendere e il dare; e l’abisso più stretto è il più duro da superare». Nietzsche
Il poeta si incammina sulle tracce degli Dèi fuggiti, dei nostri istanti irrigiditi. Il poeta immagina, e la lingua sogna in lui: spiccano il volo le parole nella foresta dell’Immaginazione, diversa da quella (la foresta) della Realtà, per un solo – insignificante? – particolare: una foresta agisce dentro di noi e l’altra fuori. Ecco l’incrocio simbolico (il chiasmo). Figura retorica del soprannaturale.
Ma il dentro è fuori e il fuori è dentro. E noi siamo – i poeti lo sono – la reversibilità della lingua. Scala di Giacobbe del senso, «fioriture successive».