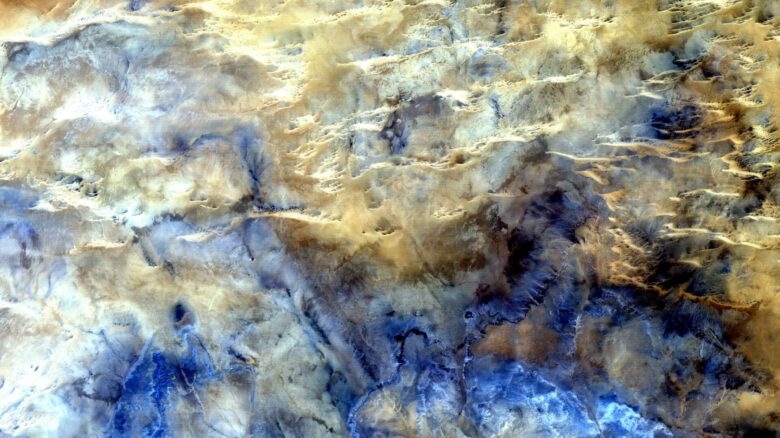Nel 1977 usciva postumo, dodici anni dopo la morte di Ernesto de Martino, il libro in cui si sarebbe dovuta compiere la sua traiettoria intellettuale: La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali. In quel testo trovavano spazio, riletti alla luce di preoccupazioni scientifiche nuove, i temi che avevano costellato gli scritti precedenti dell’autore – dalla presenza al mondo e la sua possibile crisi alla morte, dall’efficacia del rituale alla vita culturale dei subalterni. Tuttavia, l’intero sforzo intellettuale di de Martino veniva ora mobilitato per mettere a tema una questione quanto mai attuale anche per noi, lettori contemporanei e retrospettivi: la possibilità che il mondo finisca.
La fine del mondo sarebbe rimasto un progetto incompiuto. De Martino, infatti, morì prima di poterlo terminare, lasciando ai propri allievi il compito di comporre le «note sparse»1, come avrebbe scritto Clara Gallini, curatrice del tomo, per farne un’opera fruibile. Ne sarebbe risultato un volume straordinario e peculiare, capace di essere indicato come lascito intellettuale e «libo-summa»2 dell’opera demartiniana e di mantenere tuttavia all’interno della sua traiettoria uno statuto ambiguo e sospeso, come testimonia la sua singolarissima storia editoriale. Il volume, infatti, è stato recentemente ripubblicato adottando una nuova versione del testo, stabilita da nuovi curatori (Giordana Charuty, Daniel Fabre e Marcello Massenzio) in occasione della traduzione francese per le edizioni dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, accompagnato da un nuovo apparato curatoriale. Di questa nuova – e necessaria – edizione va tuttavia rilevata una distonia con lo spirito generale del tempo presente. La fine del mondo è, oggi, un tema quanto mai attuale. Se dopo la fine della Guerra fredda si era pensata chiusa un’epoca definita dalla minaccia nucleare che incombeva sul pianeta intero («fine del mondo come gesto tecnico della mano», «apocalissi premendo un bottone»3, scriveva de Martino), non soltanto l’ecatombe nucleare è ritornata drammaticamente presente nei nostri orizzonti, ma il riscaldamento globale, come gli scienziati avvertono con sempre maggiore urgenza, minaccia l’abitabilità di ampie parti del pianeta, aprendo a scenari catastrofici tanto dal punto di vista umanitario quanto da quello politico. Eppure, va constatato che, nell’apparato curatoriale del testo, la consonanza tra la trattazione demartiniana e lo spirito del tempo presente non viene messa a tema. È da concludersene che La fine del mondo sarebbe un libro desueto, da consegnare alla storia del pensiero rinunciando in partenza all’ipotesi di poterlo impiegare per capire il presente?
Facciamo un passo indietro. L’utilizzo demartiniano del concetto di apocalisse è singolare. Per comprenderlo, è necessario partire da una distinzione, che l’autore avanzò, ancora in vita, in un articolo in qualche modo preparatorio per l’opera, tra quelle che chiamò «apocalissi culturali» e le apocalissi invece «psicopatologiche»4. De Martino era un lettore vorace e un pensatore eclettico, e la sua analisi delle apocalissi si confronta con un dossier vario ed esteso, che va dalla storia antica, all’etnologia, alla filosofia, riservando inoltre un’attenzione precipua alla letteratura psichiatrica (di matrice fenomenologica) sui vissuti di fine del mondo. Ed è a quest’altezza che si staglia quella dicotomia fondamentale. Le «apocalissi culturali», scrive de Martino, «sono manifestazioni di vita culturale che coinvolgono, nell’ambito di una determinata cultura e di un particolare condizionamento storico, il tema della fine del mondo attuale. [… Il tema] non comporta necessariamente la fine del carattere mondano dell’esistenza umana, ma può anche assumere il carattere sociale e politico della fine di un certo mondo storico e dell’avvento di un mondo storico migliore». Intesa in questo senso, l’apocalisse appartiene, agli occhi dell’etnologo napoletano, al regno della produzione culturale: essa costituisce un trascendimento della fine e una proiezione al suo al di là che, nel preconizzare la fine di un mondo, già comincia a imbastirne uno nuovo. L’«apocalisse psicopatologica» assume tutt’altro significato. Il «documento psicopatologico», scrive de Martino, «ci mette in rapporto con un comune rischio umano di crisi radicale, rispetto al quale le diverse apocalittiche culturali, comunque atteggiate, si costituiscono tutte come tentativi, variamente efficaci e produttivi, di mediata reintegrazione in un progetto comunitario di esserci-nel-mondo».
In quest’altro volto dell’apocalisse, appare – agli occhi dell’autore – una dimensione del rischio più radicale e universale, ma soprattutto definitiva: se l’apocalisse culturale presenta un rischio già trattato, già messo in forma e proiettato al di là di se stesso, quella psicopatologica ci mette di fronte – nel linguaggio enfatico di de Martino – «all’apocalisse come rischio di non poterci essere in nessun mondo possibile, in nessuna operosità socialmente e culturalmente validabile, in nessuna intersoggettività comunicante e comunicabile». L’apocalisse psicopatologica manifesta, in altri termini, un fallimento fondamentale della cultura nella sua dimensione istituente, nella sua capacità e nel suo compito di messa in forma del mondo umano. Da un lato, allora, vi è una crisi nella cultura, o, per meglio dire, una cultura della crisi: la narrazione apocalittica – o ‘apocalisse culturale’ – raccoglie un collettivo attorno al progetto di un mondo nuovo a venire. Dall’altro, vi è una crisi della cultura: l’apocalisse psicopatologica ha luogo dove la cultura fallisce nel suo compito di fondazione di un mondo umano.
La fine del mondo, così intesa, è possibilità che rimane sempre presente in filigrana al mondo stesso; e che, se presa adeguatamente in considerazione e messa in forma, può tramutarsi in solida fondazione per un mondo nuovo. Dove fallisce l’impresa collettiva, tuttavia, dove si sfibrano le maglie della cultura, lì incombe la pura negatività dell’apocalisse individuale, «disintegratric[e] e improduttiv[a]». La trattazione demartiniana manifesta chiaramente l’orizzonte idealista della sua formazione – che lo aveva portato per esempio a liquidare il lavoro di Michel Foucault sulla follia, che sarebbe stato in seguito accostato al suo lavoro da tanti interpreti, affermando che «della follia non si può fare storia». Eppure, al netto di questa differenza fondamentale, vorrei qui indicare un sentiero lungo il quale il lavoro di de Martino può essere mostrato approssimarsi alla strada percorsa dall’antropologia contemporanea, con particolare riferimento a quella che nella crisi ecologica ha trovato l’occasione per un rinnovamento speculativo5.
La chiave di lettura che vorrei qui suggerire risiede nel libro che è da ritenere il vertice speculativo di de Martino: Il mondo magico. Pubblicato nel 1948, si tratta di un libro troppo spesso ridotto a laboratorio dei lavori che lo avrebbero seguito. Lì de Martino si era spinto nel mondo della magia per catturare un momento – logico più che storico – in cui «l’unità del mondo e dei suoi oggetti» è una realtà ‘condenda’6, ovvero mai data, da fondare, da costruire. È da lì che proviene l’idea che, seppur smussata nella sua radicalità, sopravvive tuttavia nella sua opera postuma, che vuole che il mondo sia innanzitutto impresa collettiva – e l’apocalisse innanzitutto fallimento di un’impresa umana. Quello che potrebbe sembrare il segno di un umanesimo irriducibile, destinato a rendere il lavoro di de Martino inconciliabile agli orizzonti teorici dell’antropologia contemporanea, può allora essere indicato – se letto sullo sfondo del dramma ontologico messo in scena ne Il mondo magico – come traccia di un ante litteram costruttivismo demartiniano.
Dopo tutto, uno tra i più fini pensatori degli ultimi decenni, Bruno Latour, ha visto nella crisi ecologica lo stimolo a riconcettualizzare la politica, definendola come «composizione progressiva del mondo comune7». Quella contemporanea, allora, non sarebbe una crisi della natura, bensì, casomai, una crisi del concetto di Natura: dell’idea, cioè, che vi sia un mondo estraneo alle vicende umane, prima della storia, al di là della cultura. La crisi ecologica sarebbe dunque interpretabile come la sopraggiunta obsolescenza di quell’idea: la ‘natura’ oggi ha fatto ingresso nella storia e, contrariamente alle aspettative, non porta consenso e unanimità, bensì conflitti ulteriori. È esistito un tempo in cui si era sperato che l’avanzata dei partiti verdi avrebbe corrisposto a una nuova coscienza politica – addirittura Michel Serres aveva parlato di un «contratto naturale». Oggi, è tragicamente evidente che è accaduto il contrario: per dirla con de Martino, la natura – il mondo comune – appare come un «compito», e non come una premessa.
Certo, la crisi ecologica contemporanea sembra sfidare la concettualità demartiniana, nella misura in cui il «rischio di non poterci essere in nessun mondo possibile» è oggi una realtà concreta e per nulla virtuale, rappresentando anzi la destinazione a cui siamo collettivamente diretti a meno che non avvenga un improvviso, repentino e profondo mutamento nelle nostre abitudini collettive. Non è l’apocalisse psicopatologica ad attenderci dove rischia di fallire una genuina cultura apocalittica che non cessa di ripetere che il business as usual ci destina al disastro (non solo, perlomeno: i problemi legati alla cosiddetta ‘ecoansia’ sono con ogni probabilità solo la punta dell’iceberg dei malesseri anche psicologico-individuali in vario modo riconducibili alla crisi ecologica), bensì qualcosa che de Martino non poteva immaginare: una vera e propria ‘apocalisse naturale’. Naturale non nel senso che capiti in virtù di circostanze che sfuggono al nostro controllo, compiendo un destino deciso altrove, bensì che non riguarda solo un mondo culturale, ma la possibilità stessa di costruire mondi a venire. Tuttavia, l’eredità demartiniana può aiutarci a vedere come la «composizione progressiva» di quel mondo futuro passa, di necessità, dall’accompagnare questo alla fine. Non facendosi profeti di sventura («la fine è vicina!») o alimentando l’appeal tutto conservatore di un catastrofismo spicciolo, bensì creando una cultura che sia all’altezza di quella fine.
Note
- C. Gallini, Introduzione, in E. de Martino, La fine del mondo. Contributo allo studio delle apocalissi culturali, Torino, Einaudi, 1977, pp. ix-xciii, p. xviii
- Ibidem
- E. de Martino, Furore simbolo valore, Il Saggiatore, Milano, 2013, p. 116
- E. de Martino, Apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche, in “Nuovi Argomenti”, n. 69-71, pp. 105-41, 1964; oggi ripubblicato in appendice a E. de Martino, La fine del mondo. Contributo allo studio delle apocalissi culturali, Einaudi, 2019
- P. es. D. Danowski e E. Viveiros de Castro, Esiste un mondo a venire? Saggio sulle paure della fine, Nottetempo, Milano 2017
- E. de Martino, Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo, Paolo Boringhieri, Torino 1973, p. 232
- B. Latour, Politiche della natura. Per una democrazia delle scienze, Raffaello Cortina Editore, Milano 2000, p. 11